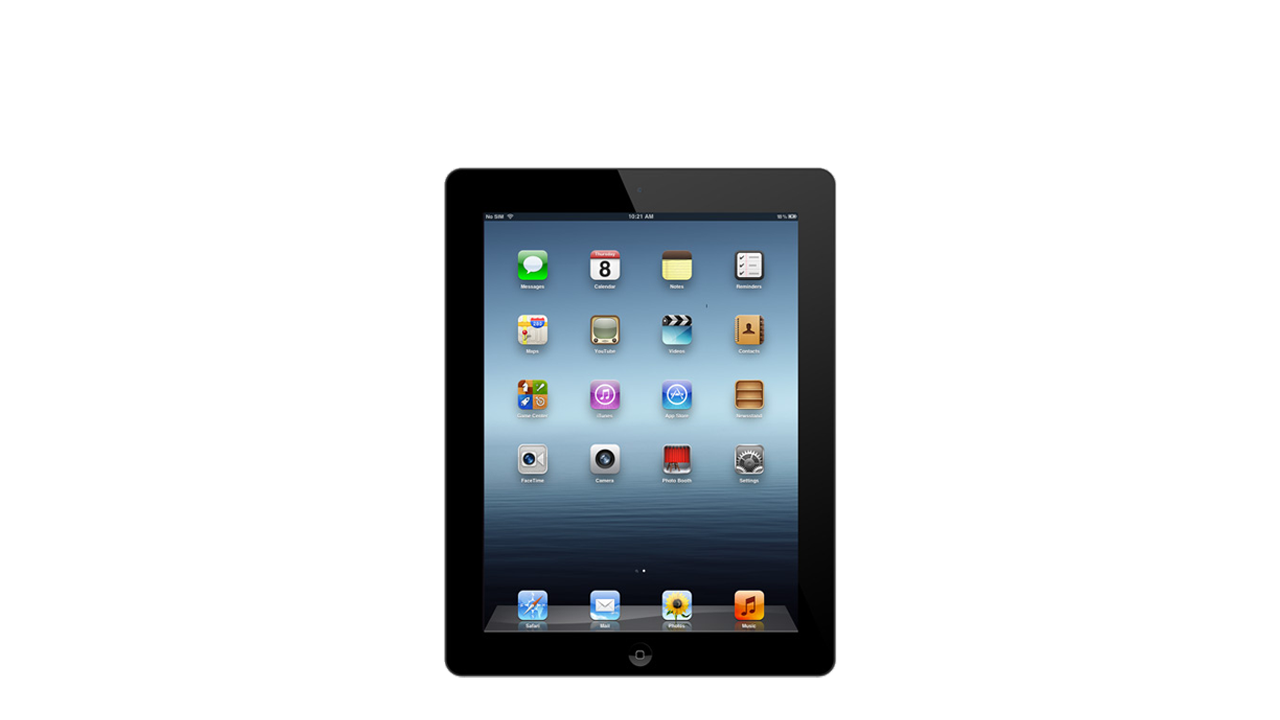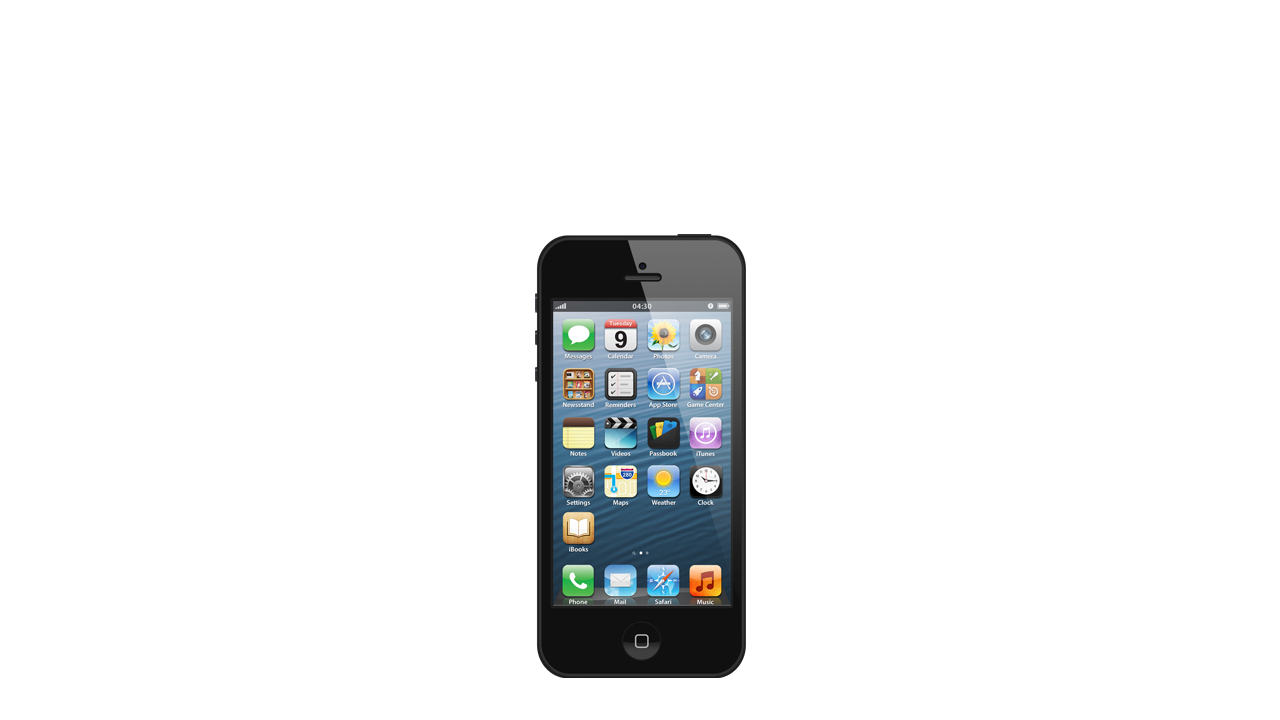Il mannitolo – detto anche mannite – è un carboidrato semplice ed appartiene alla categoria dei polialcoli esaidrici, ovvero presenta sei gruppi idrossilici (OH), distribuiti lungo una catena alifatica composta da altrettanti atomi saturi di carbonio.
Questo alcool esavalente si può trovare in molti vegetali, in cui svolge il ruolo di attirare acqua e garantire quindi la sopravvivenza della pianta nei momenti di siccità: tra le specie arboree più ricche di mannitolo (o mannite) è bene ricordare il frassino – se ne trova circa il 30-60% – ma la mannite si trova anche nel tallo delle laminarie e del fucus (le cosiddette alghe marine), nelle foglie e nelle drupe dell’olivo, nel fico, nel sedano ed in funghi eduli come Lactarius spp. e Agaricus spp.
La manna – un essudato zuccherino formato principalmente da mannite e da altre componenti residuali come gli zuccheri, i minerali e le resine – viene prodotta dalla pianta quando quest’ultima si trova in situazione di stress idrico, ed è in grado di conferire proprietà particolarmente benefiche.
Infatti, è conosciuta la presenza del mannitolo sia a livello industriale – è infatti spesso utilizzato come dolcificante acariogeno per diabetici – sia a livello medico e salutistico: esso viene infatti impiegato come lassativo e come diuretico, ed anche per valutare la salute della mucosa intestinale.
Nel primo caso, il mannitolo – che dal punto di vista alimentare appartiene alla categoria degli stabilizzanti, addensanti, gelificanti ed emulsionanti – veniva in passato utilizzato come dolcificante in sostituzione dello zucchero: esso presenta un potere dolcificante leggermente superiore alla metà di quello del saccarosio ma ha un potere calorico che è superiore alla metà di quello del saccarosio stesso. Il suo potere lassativo, tuttavia, ne limita l’uso in tal senso: se è assunto in via orale, infatti, questo dolcificante si comporta come un vero e proprio lassativo osmotico, richiamando acqua nel lume intestinale ed aumentando volume e morbidezza delle feci. Inoltre, se utilizzato in grandi dosi, il mannitolo ha degli effetti collaterali come crampi, flatulenza e dolori addominali.
Quando il mannitolo è invece assunto per via parenterale – ovvero per mezzo di infusione endovenosa di una soluzione acquosa al 20%, nell’arco di 15-30 minuti – esso serve più da diuretico osmotico, per la sua acclamata capacità di richiamare acqua all’interno dei tubuli renali: tuttavia, in questo caso va valutata l’assunzione endovenosa di questo prodotto in quanto esso è sconsigliabile ai pazienti ipotesi (ovvero con pressione bassa), ipovolemici (come appunto pazienti che presentino un alto tasso di disidratazione), collassati, con anuria o con insufficienza cardiaca congestizia.